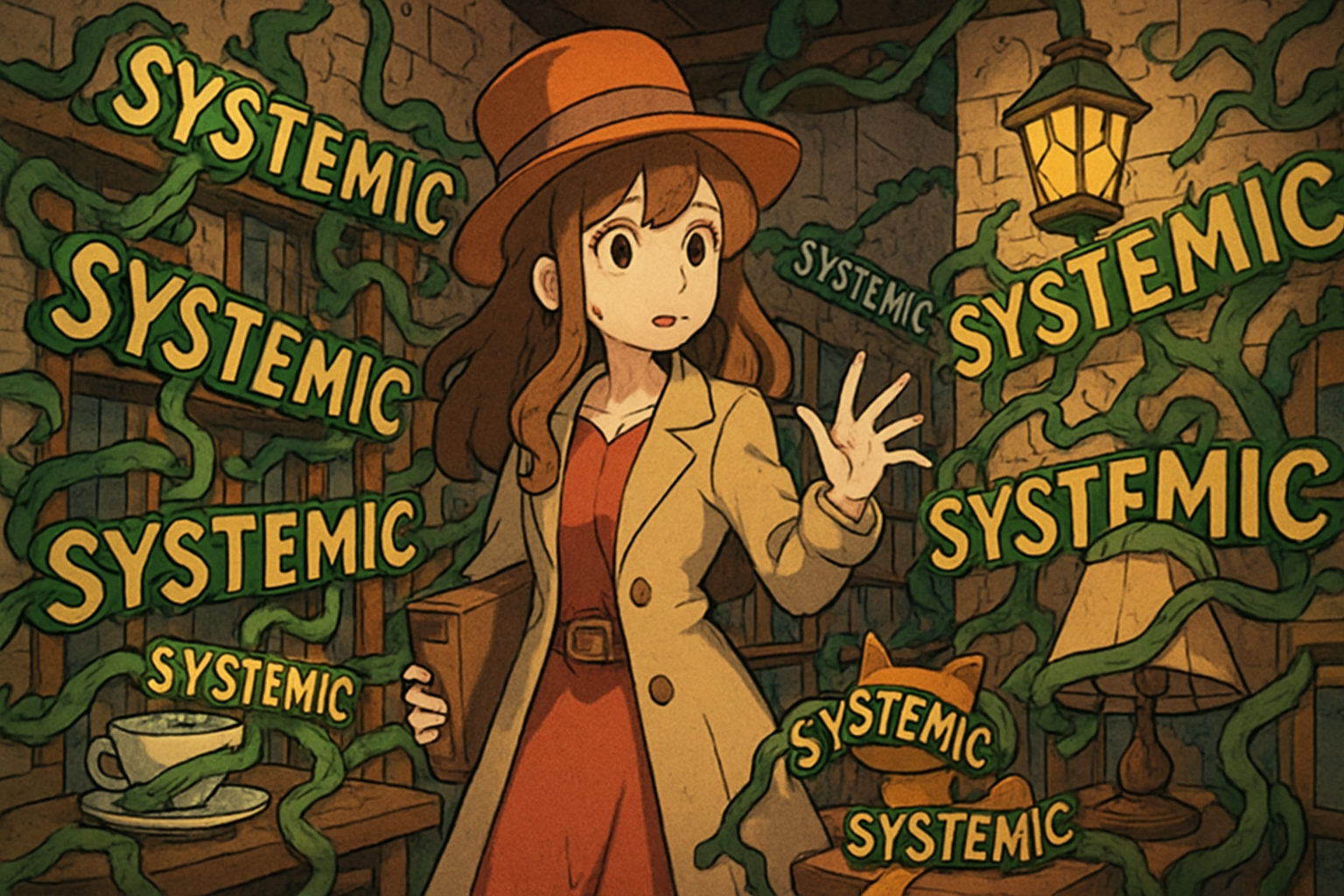In molti ambienti femministi contemporanei, alcuni slogan nati con buone intenzioni si sono trasformati in dogmi che ostacolano il pensiero critico.
Sorella, io ti credo
Uno dei più emblematici è “Sorella, io ti credo” (o “Believe women”).
Nato per esprimere sostegno alle vittime di violenza, questo principio nella pratica scivola facilmente in un’altra direzione: l’automatica colpevolezza maschile e l’infallibilità femminile.
Sostenere chi denuncia è doveroso. Credere ciecamente senza verifica, invece, è pericoloso: significa rinunciare a un pilastro fondamentale della giustizia, la presunzione di innocenza. Se partiamo dal presupposto che ogni accusa è vera e ogni uomo accusato è colpevole fino a prova contraria, non promuoviamo giustizia: promuoviamo pregiudizio.
Patriarcato sistemico
Un’altra parola abusata è “sistemico”.
Qualunque episodio negativo viene subito inserito nella narrativa del sistema patriarcale, senza analisi concreta dei contesti e delle proporzioni.
Un’aggressione, un comportamento scorretto, perfino un’impressione soggettiva, diventano automaticamente la “prova” che il sistema è onnipresente e irreparabile.
Così facendo:
- si evita di ragionare sui singoli casi,
- si impedisce di distinguere gravità e contesti,
- si rischia di svuotare il concetto stesso di “sistema” fino a renderlo inutile.
Inoltre, l’etichetta “sistemico” viene applicata in modo selettivo: la violenza sulle donne viene giustamente riconosciuta come fenomeno sistemico, ma la violenza psicologica, economica o giuridica subita da uomini separati, ad esempio, viene derubricata a episodi isolati.
Chi decide cosa è sistemico e cosa no? Non è mai chiaro.
Cultura dello stupro
Un altro concetto che andrebbe maneggiato con maggiore attenzione è quello di “cultura dello stupro”. Formulato per denunciare ambienti in cui la violenza sessuale viene banalizzata, oggi viene generalizzato a tutta la società occidentale, come se lo stupro fosse socialmente tollerato o incoraggiato. In realtà, gli stupratori sono perseguiti per legge, stigmatizzati a livello sociale, e le vittime, pur tra difficoltà, ricevono sempre più protezione e ascolto. Dove esistono ancora problemi — come carenze nella gestione dei processi — si tratta di limiti del sistema giudiziario, non di una normalizzazione culturale della violenza.
Etichettare indiscriminatamente una società come “cultura dello stupro” rischia di oscurare i reali progressi fatti, di creare sfiducia generalizzata e di banalizzare la lotta vera contro ogni forma di violenza sessuale.
Maschio-bianco-etero-cis
Infine, l’identità degli uomini viene spesso ridotta a un’etichetta: “maschio bianco etero cisgender”.
Un’espressione che, più che analizzare privilegi o responsabilità reali, finisce per:
- cancellare la complessità individuale,
- attribuire automaticamente colpe storiche e sistemiche,
- disumanizzare chi appartiene a quella categoria.
In questa visione, la misandria — l’odio verso gli uomini — viene non solo normalizzata, ma a volte giustificata: “Gli uomini ci hanno oppresse per secoli, ora devono pagare.” Oppure: “La misandria non uccide nessuno, la misoginia sì.”
Ma l’odio, da qualunque parte provenga, è sempre disumanizzante. E anche l’odio verso gli uomini produce conseguenze reali: isolamento, stigmatizzazione, difficoltà a chiedere aiuto, marginalizzazione emotiva.
Esempi
«[…] perché non esiste un termine per indicare l’omicidio di un uomo in quanto uomo?» La risposta suonerà banale, ma rispecchia le statistiche: perché non ce n’è bisogno. Sono assolutamente certa che nel mondo ci siano stati uomini ammazzati per non essere stati abbastanza uomini, per non aver rispecchiato lo stereotipo del maschio alfa, per non aver saputo badare alla famiglia, per non essere stati sufficientemente forti (anzi, di solito si ammazzano da soli). […] In Italia i dati parlano di un femminicidio ogni tre giorni. Ogni tre giorni una donna viene ammazzata per non essere stata donna nel modo “giusto”. Accade così spesso che abbiamo dovuto inventare una parola per parlarne in maniera concisa, dobbiamo parlarne così spesso che ci serviva un termine che riassumesse il fatto. Maschicidio non è un termine utilizzato perché quando accade se ne parla nel dettaglio.
Viviamo in una cultura dello stupro perché una donna su tre è vittima di stupro. La maggior parte delle violenze è da parte di mariti, fidanzati, amanti. L’80% degli stupri non è denunciato.
“Sorella, io ti credo. O del perché è necessario ridare prospettiva e centralità al concetto di sorellanza”: https://archive.ph/XeWno
“Le femministe che ora sostengono di non aver mai voluto dire ‘credete a tutte le donne’ stanno facendo gaslighting”, Robby Soave: https://archive.ph/8nbUL
“‘Sorella, io ti credo’ è uno slogan incompatibile con la presunzione d’innocenza”, Guido Vitiello: https://archive.ph/0N8hs
“Il femminicidio è sistemico e culturale”: https://archive.ph/vbNpc
“La violenza sulle donne non è solo un’emergenza, ma un problema sistemico”, Alessia Dulbecco: https://archive.ph/QlKHq
“’Non c’è un problema di femminicidi’ sono i nuovi terrapiattisti”, Luca Sofri: https://archive.ph/gw0ji
“Cultura dello stupro”, Irene Facheris: https://www.youtube.com/watch?v=EiOI5z7I5E4
“Il principio di presunzione di non colpevolezza, quando l’autore di violenza è un uomo dotato di prestigio e potere, rischia di tradursi in presunzione di mendacia della donna”, associazione D.i.Re: https://archive.ph/ZqYJj
Letture e approfondimenti
Meghan Daum, The Problem with Everything: My Journey Through the New Culture Wars
- esplora le contraddizioni del femminismo contemporaneo e del movimento #MeToo. Critica l’adozione acritica dello slogan “Believe Women”, sostenendo che possa compromettere il principio della presunzione di innocenza e alimentare una cultura della cancellazione. Il libro offre una riflessione personale sulle tensioni tra giustizia sociale e libertà individuale.
Reah Bravo, Complicit: How Our Culture Enables Misbehaving Men
- Bravo, una delle accusatrici di Charlie Rose, analizza le dinamiche di complicità culturale che permettono agli uomini potenti di perpetuare comportamenti abusivi. Riflette anche sulle proprie esperienze, ammettendo complessità e ambiguità nelle relazioni di potere. Il libro mette in discussione la narrazione binaria vittima-colpevole, evidenziando le zone grigie spesso trascurate nel discorso pubblico.
Helen Pluckrose & James Lindsay, Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody
- Gli autori criticano l’adozione di concetti come il patriarcato sistemico senza un’adeguata base empirica.
- Viene affrontato anche come la politica identitaria e l’intersezionalità possano degenerare in modelli riduttivi che appiattiscono l’esperienza individuale e incoraggiano giudizi morali basati sull’appartenenza a un gruppo. Gli autori sostengono che tali approcci rischiano di disumanizzare gli individui trattandoli come semplici rappresentanti del privilegio o dell’oppressione.
Randy Thornhill & Craig Palmer, A Natural History of Rape
- Gli autori propongono una spiegazione evoluzionistica dello stupro, contestando l’idea che esso sia esclusivamente un prodotto culturale del patriarcato.